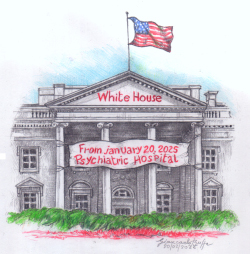1. È fondato il rischio che il prossimo referendum sulla legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare approvata dalle Camere diventi uno scontro frontale tra Governo e Magistratura. Vanno in tale direzione le dichiarazioni dei vertici del Governo rivolte all’eliminazione delle presunte “invasioni di campo” operate da una magistratura politicizzata che pretendono, da parte di chi non è eletto dal popolo, di contrastare le decisioni assunte dall’esecutivo e dal Parlamento. L’idea che la magistratura ordinaria, poi affermata anche per quella europea e per quella contabile, non possa in alcun modo contrastare l’azione del Governo costituisce una violazione del principio della separazione dei poteri, che assegna alla magistratura il compito di controllare la conformità alla Costituzione, alla normativa europea e al diritto internazionale delle delibere di Governo e maggioranza parlamentare, anche di natura normativa, specie quando riguardano le limitazioni di diritti fondamentali. Negare tale ruolo e immaginare che esistano santuari politici che devono essere immuni da controlli e da sanzioni di tipo giurisdizionale costituisce una violazione dello Stato di diritto costituzionale, il quale consente di impugnare le decisioni della magistratura facendo ricorso ai rimedi stabiliti dalla Costituzione e dall’ordinamento giuridico, ma non di delegittimare un intero corpo dello Stato titolare di un potere fondamentale per l’esistenza di una democrazia costituzionale. D’altro lato l’ANM ha deciso di dare vita a un proprio Comitato per il No che parteciperà alla campagna referendaria. Si tratta di una scelta che non è certamente illegittima, in quanto la Costituzione consente alla magistratura di esprimere la propria opinione sulle politiche relative alla giustizia e, come si verifica nel caso specifico, di chiedere al corpo elettorale di respingere una legge che interviene sulla carriera e sulla responsabilità disciplinare dei magistrati e sull’organo rappresentativo che ne garantisce l’indipendenza e l’autonomia. Né si può parlare di delegittimazione e di violazione dell’imparzialità, in quanto la presenza nella campagna referendaria non trasforma affatto l’ANM in un partito politico, come avviene per le associazioni rappresentative della società civile che decidano di parteciparvi. Piuttosto si può avere un dubbio sull’opportunità della decisione dell’ANM per il rischio che possa apparire come un arroccamento di tipo corporativo indirizzato contro il Governo e la maggioranza parlamentare. A scongiurarlo può essere importante l’apertura del Comitato dell’ANM al contributo di personalità qualificate e di esponenti dell’associazionismo, ad esclusione dei partiti politici. In tale direzione è andata la designazione come Presidente di un qualificato costituzionalista come Enrico Grosso, il quale ha subito avuto modo di precisare che il Comitato opera “a tutela della Costituzione” e contro la riduzione degli spazi stabiliti a garanzia dei cittadini.
2. La questione fondamentale che va posta al centro del referendum riguarda l’incidenza che la legge approvata può avere sulla tutela giurisdizionale dei diritti. La separazione delle carriere proposta va in direzione della configurazione di pubblici ministeri distaccati dalla comune cultura della giurisdizione e con un proprio CSM nel quale saranno in maggioranza. Ciò accentua la tentazione di operare non come magistrati, che tengono conto anche delle prove favorevoli all’indagato o all’imputato, ma come superpoliziotti che sostengono l’ipotesi accusatoria anche se di scarsa consistenza. In questo quadro i p.m. potrebbero trovarsi non a dirigere la polizia giudiziaria, ma a inseguire le indagini da questa effettuate. Ciò comporta una minore tutela dei diritti, che si accentuerebbe qualora si utilizzasse in futuro l’esito di un peso eccessivo acquisito dai p.m. per subordinarli al Governo, il che potrebbe in parte avvenire anche con una legge ordinaria sulle garanzie del p.m. ex art. 107, c. 4, Costituzione. La prospettiva è tanto più preoccupante alla luce dell’indirizzo panpenalistico perseguito dall’attuale maggioranza, fondato su moltiplicazione dei reati e accentuazione delle pene per chi ricorre a manifestazioni pacifiche di dissenso e nei confronti dei più deboli (come immigrati e carcerati), mentre nel contempo vengono aboliti reati e accentuate le garanzie per i “colletti bianchi”.
3. La triplicazione del CSM non può che indebolire il ruolo dell’attuale organo di garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura, creando una situazione di caos, nella quale oltre a non esservi collegamenti tra i due Consigli dei giudici e dei p.m. e tra i rispettivi uffici giudiziari, non si sa a chi spetteranno le attuali competenze propositive e consultive, se la formazione dovrà spettare all’attuale Scuola superiore della magistratura o essere differenziata, quale sarà l’assetto dei Consigli giudiziari distrettuali. Vi è poi il rischio che le competenze sulla carriera dei magistrati (come le nomine di direttivi e semidirettivi e le valutazioni di professionalità) siano esercitate dai due Consigli di più ridotta competenza e di minore efficienza e positività sul funzionamento della giustizia, anche in considerazione della modalità della loro composizione, il che non avvantaggerebbe certo gli utenti del servizio.
4. Una considerazione attenta va fatta sul ricorso al sorteggio per la designazione dei magistrati facenti parte dei due Consigli e dell’Alta Corte disciplinare. Il ricorso al sorteggio viene previsto perché porterebbe alla sparizione delle “correnti”. Ora, tale esito non è affatto certo, in quanto è probabile che sia sorteggiato un buon numero di appartenenti alle stesse, ma più in generale la demonizzazione delle associazioni va a colpire non le degenerazioni di tipo sindacal-corporativo, ma il pluralismo interno alla magistratura che in passato e si spera in futuro ha consentito un confronto sul funzionamento della giustizia e sulle linee di attuazione delle disposizioni costituzionali che la riguardano. Sono evidenti i danni che il sorteggio produrrebbe. Intanto sopprimerebbe la rappresentatività della componente togata derivante dalla elezione da parte di tutti i magistrati, il che non può essere giustificato dalla natura amministrativa o dal ruolo meramente garantista del CSM, dimenticando la sua configurazione, fatta propria dalla Corte Costituzionale, come “organo di rilievo costituzionale” che provvede al governo autonomo della magistratura. In secondo luogo il sorteggio darebbe spazio alla casualità in base al principio per cui “uno vale uno”, che può garantire l’accesso alla carica di magistrati non rappresentativi e privi di capacità programmatiche e organizzative. Non è un caso se il sorteggio non viene applicato né per i Consigli di presidenza delle altre magistrature, né per gli ordini professionali, né nei vari settori della pubblica amministrazione, né per gli organi e le autorità di garanzia. Il danno ai diritti dei cittadini deriverebbe oltre che dalla probabile più ridotta qualità della composizione, dallo spazio che il sorteggio darebbe a posizioni personali e carrieriste e alla trasversalità di accordi-ombra tra componenti del Consiglio e uomini politici (com’è avvenuto con il caso Palamara).
5. L’Alta Corte disciplinare è un concentrato di difetti: vale solo per la magistratura ordinaria e non per quelle speciali, deroga al principio dell’eguaglianza tra i magistrati sancito nella Costituzione affidando la carica di membro togato solo a chi è stato o è magistrato di legittimità, abolisce l’impugnazione delle decisioni di primo grado alla Corte di Cassazione con probabile violazione dell’art. 111, c. 7, della Costituzione. Si tratta quindi di un organo che mortificherebbe la grande maggioranza dei magistrati senza renderli affatto più responsabili nei confronti dei cittadini, come dimostra l’alto numero di procedimenti e di sanzioni disposte dal CSM quale titolare della competenza disciplinare che non ha eguali in altri ordini pubblici e privati.
6. In conclusione occorre auspicare che il referendum permetta un confronto informato sui temi trattati dalla legge. Personalmente ritengo che si debba dire No ad una “riforma” che non risolve in alcun modo i problemi di funzionamento della giustizia, a cominciare dalla eccessiva durata dei processi, e indebolisce il ruolo della magistratura ordinaria come corpo unitario e indipendente, in tal modo riducendo la tutela giurisdizionale dei diritti.
Mauro Volpi già Professore di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Perugia e membro laico del Consiglio superiore della magistratura.
7 novembre 2025