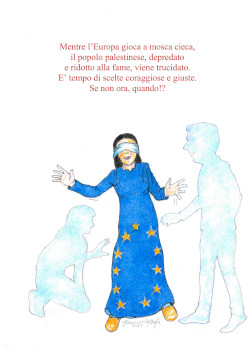I conflitti contemporanei non lasciano ferite soltanto nel tessuto sociale e nelle città distrutte, ma soprattutto nelle vite dei bambini, costretti a crescere in un ambiente segnato da paura, privazioni e morte. I piccoli di Gaza, che sopravvivono a bombardamenti continui e alla perdita di intere famiglie, porteranno dentro di sé un dolore destinato a non spegnersi mai. Lo stesso accade ai bambini ucraini, esposti da anni a un conflitto che ha spazzato via la normalità, e ai bambini delle regioni russe colpite dalla guerra, anch’essi vittime di bombardamenti, evacuazioni forzate, separazioni dai genitori. In tutti questi contesti, l’infanzia viene violata da traumi che si sedimentano nell’inconscio, trasformando il gioco e l’innocenza in memoria del terrore.
Le neuroscienze e la psicologia ci insegnano che il trauma infantile, soprattutto quando prolungato, genera cicatrici che condizionano l’intera esistenza: disturbi del sonno, difficoltà relazionali, incapacità di fidarsi, fino a forme gravi di stress post-traumatico. Ricordare e raccontare diventa allora una pratica necessaria: non solo per elaborare il dolore, ma anche per restituire dignità e voce a chi è sopravvissuto. È in questo orizzonte che si colloca la riflessione di chi affronta il tema del setting autobiografico e delle pratiche comunicative come strumenti per sopravvivere al ricordo del genocidio e di altre esperienze di sterminio di massa.
Il setting autobiografico e le modalità comunicative per sopravvivere al ricordo del genocidio e degli stermini di massa
Nell’ambito dell’incontro narrativo, tessere la trama della propria storia significa compiere una ricognizione biografica che mette in luce gli atteggiamenti comunicativi, l’uso del linguaggio e la reciprocità dell’interscambio dialogico. L’interazione attraverso un lessico specifico e uno stile espositivo non artificioso consente al biografo di identificarsi, anche solo temporaneamente, con il soggetto intervistato. In questo modo l’intervista si trasforma in un incontro naturale, in cui l’accoppiamento comunicativo diventa risorsa di apprendimento e di significazione interiore. Ciò avviene soprattutto nelle narrazioni che emergono da contesti ostili, come quelle dei sopravvissuti a guerre, genocidi e violenze.
Nel confronto tra due testimonianze emergono spesso aspetti non affidati alle parole, ma ai gesti, alle espressioni del volto, alla postura, allo sguardo. Questi canali diventano veicoli di emozioni e sentimenti che accompagnano il racconto di atrocità subite. Narrazioni come quelle delle poche persone sopravvissute al genocidio di Gaza ne sono un esempio drammaticamente attuale.
Le esitazioni dell’intervistato possono trovare senso nel silenzio, che diventa esso stesso forma di comunicazione: pausa necessaria per placare l’ansia, l’impotenza e la minaccia percepite. Anche il silenzio più carico di angoscia può esprimere l’indicibile, costituendo parte integrante del processo narrativo.
Il **setting autobiografico** assume un ruolo decisivo: attraverso l’organizzazione dello spazio e del tempo, crea le condizioni per una relazione intima, meditativa e protetta, in cui il soggetto possa esprimersi senza interruzioni. È fondamentale che l’ambiente sia accogliente e non anonimo, capace di trasmettere fiducia e di evitare barriere artificiali, così da facilitare il racconto dei momenti più terrificanti della violenza e della guerra.
Il racconto spontaneo richiede una contrattazione iniziale che definisca stimoli e suggestioni, in modo da orientare la riflessione biografica. Il setting autobiografico permette così di affrontare le pause, gli oblii e le censure che accompagnano i vissuti traumatici, offrendo spazi di autoriflessione e autotrasformazione. Tecniche comunicative come le domande brevi o i questionari diventano strumenti per accompagnare la narrazione, non per giudicarla, ma per agevolare il processo di elaborazione del trauma.
L’analisi delle narrazioni consente di individuare ricorrenze linguistiche, frasi-chiave, strutture spezzate e travagliate del discorso, tipiche dei racconti che emergono da esperienze estreme. Ogni storia di vita va decodificata attraverso registri non solo verbali, ma anche simbolici e metaforici, capaci di aprire varchi nei mondi interiori di chi racconta.
In questo processo, l’ascolto attento e fluttuante diventa uno strumento essenziale per cogliere la trama e il trauma, per riconoscere i salti logici e le fratture della narrazione che sono il riflesso stesso della violenza subita. Le storie dei sopravvissuti restituiscono così le apicalità esistenziali dell’amore, della perdita, della morte, mostrando come il racconto possa diventare non solo memoria, ma anche possibilità di rinascita interiore.
Laura Tussi