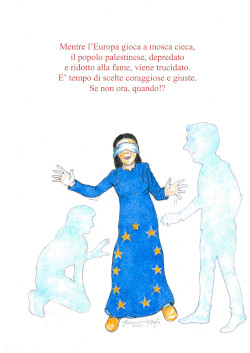Una lettura dell’invettiva di Giorgia Meloni contro la sinistra e gli odiatori seriali è che la premier sia entrata in modalità campagna elettorale. Sarebbe un appello ai tifosi della sua curva. C’è del vero, con il voto alle porte in Regioni importanti, una legge di Bilancio che Giorgetti certifica a rischio, l’economia in affanno, i dazi e le spese militari, le guerre, cui si aggiungono proposte come quella – rivoltante e immorale molto prima che antigiuridica come certamente è – di ripagare i costi del genocidio dei palestinesi costruendo un resort a Gaza sui loro cadaveri. Ma guardando al di là dell’immediato l’interpretazione può essere diversa.
Chi può intimidire chi? È risibile che dal governo – titolare del potere legislativo ed esecutivo – si contesti alle opposizioni la volontà di intimidire. È una minaccia, una diffida? In ogni caso, è arrogante cinismo politico, pericoloso e irresponsabile perché inserito in un contesto: attacco virulento ai magistrati, all’informazione, indirizzo ipersecuritario, intolleranza per il dissenso, riforme che stravolgono la Costituzione.
La domanda è: siamo avviati su un piano inclinato verso forme più o meno evidenti di autocrazia? Assistiamo a un avvitamento nel nostro Paese della crisi delle democrazie liberali, anche di quelle che avremmo un tempo ritenuto solide? Abbiamo anticorpi sufficienti contro un simile esito? La risposta: forse.
Guardiamo agli Usa, che mostrano da ultimo segni evidenti di autocrazia. L’11 settembre 2025 è stato pubblicato un libro: We the People. A history of the US Constitution. L’autrice Jill Lepore insegna a Harvard. In base a una ampia ricerca documentale, definisce la Costituzione degli Stati Uniti come quasi inemendabile, a causa di un procedimento di revisione che ha consentito solo 27 emendamenti in 250 anni: maggioranza di due terzi in entrambe le Camere, ratifica di tre quarti degli Stati. È cosa nota, che ho riscontrato scrivendo la mia tesi di Master in Diritto costituzionale, oltre 50 anni fa, sulla – fallita – riforma del Collegio elettorale. Meno scontato il corollario che l’autrice trae: l’evoluzione costituzionale del Paese rimane nelle sole mani della Corte Suprema, di fatto unica voce e interprete della Costituzione.
Qui soccorre un altro libro, del maggio 2025: Lawless. How the Supreme Court runs on conservative grievances, fringe theories, and bad vibes (si può tradurre: “Senza legge. Come la Corte suprema procede su doglianze conservatrici, teorie marginali, e cattive sensazioni”). L’autrice, Leah Litman, insegna nella Facoltà di Legge dell’Università del Michigan. Il libro attacca la Corte Suprema a maggioranza conservatrice per aver introiettato l’agenda politica e ideologica della destra repubblicana. L’analisi guarda anche – ma non solo – alla giurisprudenza più recente, dal disco verde alla seconda candidatura Trump all’espansione dei poteri presidenziali. La Corte ha determinato un cambiamento radicale e probabilmente duraturo della Costituzione e del Paese.
Ogni lettura può essere opinabile, ma queste certo riflettono una realtà. Perché ci interessano? Ci dicono che non basta discutere in astratto di checks and balances. La resilienza in prospettiva di una architettura costituzionale si valuta guardando, al di là del formalismo, al funzionamento e alle effettive fragilità. La nostra Costituzione è (troppo) facilmente emendabile, consegnando a una maggioranza anche solo di governo il potere di revisione, con il check – eventuale – del referendum. Abbiamo due guardiani della Costituzione: il Capo dello Stato e la Consulta. Ma basterebbe una legge elettorale come quella cui la destra pensa – proporzionale con soglia al 40%, liste parzialmente bloccate e premio di maggioranza – per influire decisivamente sull’elezione del primo e, anche in via mediata, sulla composizione della seconda. Un monismo istituzionale centrato sul governo e sul primo ministro non è poi lontano, anche senza la riforma del premierato.
Rimane fuori dal quadro il corpo professionale dei magistrati, difesi da una formale menzione di autonomia e indipendenza, ma ancor più dalla selezione per concorso, dall’autogoverno e dall’avere gli stessi diritti di ogni cittadino. Che la riforma preluda o meno al controllo politico dei pm, il referendum entrerà inevitabilmente nella più ampia strategia politica e istituzionale della destra. Il tempestoso voto alla Camera ci dice quanto sia vuota di senso la richiesta di Nordio di non politicizzare il referendum. Nel contesto in cui si voterà, non si potrà ridurne l’oggetto a una banale questione di carriera. Sarà in gioco non già la sorte di qualche migliaio di magistrati, ma il futuro del Paese come democrazia liberale. E l’invettiva di Meloni è l’avvio di una lunga battaglia non solo elettorale.