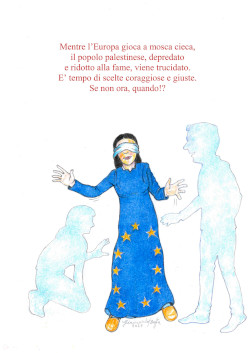L’hanno chiamato decreto «rilancio». La terminologia pokeristica ben si presta in questo caso. Infatti, salvo disperati bluff, rilancia chi ha una buona »posta» avanti a sé. Non cercate quindi i vincenti tra i lavoratori, tantomeno i precari, per non dire delle badanti.
E neppure tra gli immigrati, malgrado lo stress emotivo della ministra – che ha evocato ben tristi precedenti. Li potete trovare invece nel mondo dell’imprenditoria, nell’alleanza tra banche e imprese, tra i Carlo Bonomi e i Luigi Abete (basta leggersi le ultime recentissime interviste), cioè il presidente designato di Confindustria e il presidente di Bnl.
Si sono lamentati – esattamente come in quel detto napoletano fin troppo esplicito – che nel paese e nel governo stava montando uno «spirito antindustriale», che andavano abbassate le tasse alle imprese, tolta l’Irap, che non era colpa delle banche se l’euro s’insabbiava senza giungere a destinazione di chi ne ha bisogno fino ad assestare l’ultima spallata, decisiva, al fine di fare pendere la bilancia dalla loro parte.
La mole del decreto è impressionante. Non solo quella cartacea, oltre 250 articoli per più di 450 pagine, ma soprattutto per le sue dimensioni finanziarie. Si tratta infatti della manovra economica più grande della storia repubblicana: 55 miliardi di nuovo indebitamento, che, secondo il ministro dell’Economia, dovrebbe mobilitare 130 miliardi di liquidità. Il guaio ancora peggiore è che tutto questo volume di risorse venga disperso in una bulimia di norme, di non facile lettura (ma questa non sarebbe una novità) che testimoniano un sistema di governo e di governance che sembra rincorrere, mutatis mutandis, i fasti delle leggi di bilancio di memoria democristiana. Anche allora pareva all’inizio che il tessuto connettivo fosse rappresentato da una fitta maglia di misure redistributive.
Poi, man mano che la discussione procedeva, prima nelle commissioni, sorvegliate a vista dai vari lobbisti padroni dei corridoi di Montecitorio, poi nell’Aula, la fetta redistributiva si assottigliava sempre più, e qualche categoria rimaneva a bocca asciutta, a vantaggio di ben più corposi sostegni alle leve dominanti dell’economia. In un rigurgito di pudore il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli definisce il tutto come un «mosaico» di interventi di «indennizzo e ristoro» e Conte, sfidato sulla necessità di parlamentarizzare la discussione finora sequestrata dal governo, fa capire che la Camera potrà «ulteriormente migliorarlo».
Ma se la logica è quella prevalsa negli ultimi giorni, appare più una minaccia che una promessa. Il governo ha per ora allontanato la richiesta di una più strutturale e decisa riforma fiscale a favore delle imprese. Non gli era difficile, bastava trincerarsi dietro il carattere emergenziale del provvedimento. Allo stesso tempo ha voluto dare un segno preciso all’emergenza: infatti, dice Conte, l’abbuono della rata di giugno dell’Irap «significa erogare una forma indiretta di liquidità, lasciare nelle casse delle società somme di denaro». Da spendersi come vogliono.
A taglio incondizionato, spesa libera. Così pure gli interventi per favorire la ricapitalizzazione delle imprese, non vanno presi come il prodromo di una nuova Iri, «nessuna sovietizzazione» aggiunge il loquace Patuanelli, ma neppure alcun intervento sulla governance, chiosa Gualtieri. Questo decreto seppellisce qualunque ambizione di una svolta, foss’anche una timida curvatura nel modello di sviluppo.
Perché sia chiara, la scelta conservatrice viene ribadita a livello sociale. I tre miliardi per il reddito di emergenza si sono liquefatti ai primi caldi, sono diventati uno solo per una platea che piuttosto che diminuire aumenta. Del reddito universale manco si parla. Tutto rientra nei tradizionali ma sempre più usurati binari del welfare e del workfare, la cui insufficienza strutturale è messa a nudo dalla crisi economico-pandemica.
L’enfasi posta sulla tardiva regolarizzazione dei migranti non copre la delusione per le decine di migliaia di persone lasciate fuori dal faticoso accordo di maggioranza e soprattutto perché si è guardato solo alle braccia di lavoro mancanti e non a donne e uomini portatori di diritti. E non manca la beffa: verso il personale sanitario tanto lodato quanto gabbato, deprivato dei promessi mille euro.
La monumentale manovra già viene giudicata insufficiente e si parla di un nuovo decreto da 20 miliardi, si chiamerebbe «per la Rinascita». La fantasia nominalistica non manca ma difficilmente può trarre in inganno.