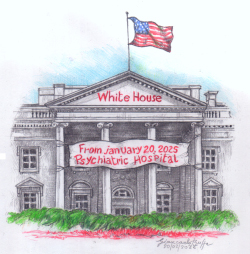E' nato un movimento. Un movimento ampio, attorno a uno sciopero generale, in solidarietà con la Flotilla, soprattutto in solidarietà con Gaza e contro il genocidio in corso. Lo sciopero del 22 settembre ha messo in mostra una forza dentro alla società italiana – tra il mondo del lavoro e studentesco, ma molto più generalizzabile – di cui si percepiva la consistenza, in particolare sui social network ma in generale in tutti i luoghi sociali. E si è davvero rispolverato un immaginario dello sciopero, e di quello generale, come da tanto non avveniva nel nostro paese.
Cortei e presidi sono andati oltre le previsioni ovunque, con blocchi della circolazione – meno della produzione – e con la capacità di attirare le forze più diverse. Va dato merito a Usb, Adl, Cub e Sgb di aver saputo cogliere la necessità di questa data anche per la sua convergenza con l’avvio in mare aperto della spedizione della Global Sumud Flotilla. La data del 22 settembre ha avuto infatti una forza decisiva perché lanciata dai Portuali di Genova che hanno dato credibilità alla parola d’ordine «Blocchiamo tutto» grazie al blocco del trasporto delle armi prima e poi al sostegno alla Flottilla. Ma lo «sciopero per Gaza» è andato davvero molto oltre ogni delimitazione organizzativa. Un popolo si è ripreso lo sciopero generale, che non appartiene alle organizzazioni sindacali ma a lavoratori e lavoratrici.
A Roma le persone si ammassano per ore a Piazza dei Cinquecento rendendo quasi impossibile contarle, con la stessa questura che cambia più volte i numeri, con la partecipazione che supera ampiamente le 100 mila persone, in grado di circondare la Stazione Termini provocandone la momentanea chiusura per poi dopo diverse ore animare un grande corteo che è riuscito a salire anche sulla tangenziale bloccandola (con applausi degli automobilisti) e ha infine occupato la facoltà di Lettere alla Sapienza. Oltre 50 mila persone a Milano dove l’irruzione in stazione Centrale ha provocato la reazione sproporzionata della polizia che ha portato ad alcuni feriti e fermi dando il segno di quale sarà la risposta del governo e delle destre a questo movimento, provando per questa via a oscurare anche mediaticamente la partecipazione di massa. Cariche con lacrimogeni anche a Venezia, per fermare il tentativo di bloccare il porto, che invece è stato fermato a Genova e Livorno, mentre a Bologna è stata bloccata l’Autostrada e a Pisa la Fi-Pi-Li, con una violazione di massa del cosiddetto Ddl sicurezza. Grande corteo anche a Firenze e poi Napoli, Torino, Trieste, Palermo, Ancona, Bari e altre città.
Le piazze italiane, ricchissime di partecipazione e molto determinate, vanno come detto ben oltre le sigle sindacali e le loro identità, eccedono le organizzazioni e si affermano di vita propria, con una dinamica che ora andrà fatta crescere rispettandone l’autorganizzazione e i percorsi.
Proprio questa caratteristica mette in luce l’errore compiuto dalla Cgil nell’indire uno sciopero il 19 settembre, giusto e meritevole in quanto unico nel panorama del sindacalismo maggioritario europeo, ma auto-riferito, pensato più per ragioni di organizzazione che per dare una mano all’affermazione di questo movimento così ampio e al blocco concreto della produzione. Il 22 settembre sono stati veramente molti e molte le lavoratrici e i lavoratori della Cgil a scendere in piazza e scioperare, e lascia davvero stupiti la home page del sito Collettiva, il giornale della Cgil, che non dà conto della giornata, almeno fino a quando scriviamo questo articolo.
Ci sarà, speriamo, tempo per recuperare perché la tragedia umanitaria di Gaza, il genocidio perpetrato da Israele e il tentativo di pulizia etnica in atto in queste giornate, continuano ad andare avanti, così come va avanti la spedizione della Flotilla e quindi la necessità di una mobilitazione unitaria e sempre più ampia. È presumibile che una manifestazione unitaria nazionale possa essere oggi utile, ma non è detto che sia questo il percorso obbligato. I tentativi fatti il 22 settembre di bloccare alcuni snodi logistici importanti – i porti, le stazioni, le autostrade, le tangenziali – indicano gli obiettivi già individuati da chi si è mobilitato: l’idea che per aiutare Gaza occorra incidere sui gangli della distribuzione, ma anche bloccare almeno una parte consistente della produzione, è una parola d’ordine tanto spontanea quanto necessaria. Perché rimette al centro il potere di lavoratori e lavoratrici, la pratica dello sciopero come espressione di forza democratica di fronte a un dominio cieco e sordo. E perché occorre chiamare il paese tutto, e poi l’Europa, i suoi popoli, sindacati, movimenti, a un sussulto per evitare che la strage si consumi nel silenzio e soprattutto affinchè sia fermata.
La strada ancora da percorrere non è poca. Nonostante le pratiche, davvero incisive e di massa, e il blocco della circolazione che il movimento ha messo in campo, alle piazze piene non è corrisposto un blocco altrettanto generale della produzione – situazione che sarebbe stata ben diversa se il blocco fosse stato praticato in modo convergente da più sigle sindacali – tranne in ampie parti del pubblico impiego e della scuola, e va quindi rilanciata la mobilitazione per recuperare questo gap. Sapendo che si può contare su un ingrediente essenziale per la mobilitazione e in fondo sempre ricorrente quando si tratta di movimenti di massa che trascendono le condizioni materiali essenziali: l’indignazione.
La Flotilla per Gaza rappresenta, ed è questo il motivo del suo seguito e del supporto che sta avendo a livello internazionale, la manifestazione in acque di quest’indignazione e la determinazione a fare qualcosa, qualunque cosa, per inviare il segnale che Stati e governi non sanno e soprattutto non vogliono inviare. Certo, ancora il 22 settembre si sono avute importanti dichiarazioni di riconoscimento dello Stato di Palestina che non vanno sottovalutate anche se, non accompagnate da misure concrete – boicottaggio attivo dell’economia israeliana, sanzioni, taglio delle forniture militari, isolamento diplomatico –, costituiscono delle foglie di fico e più un modo per strizzare l’occhio all’opinione pubblica interna che un’effettiva strategia di solidarietà al popolo palestinese. Nondimeno, i riconoscimenti sanciscono che uno «Stato palestinese» esiste per il diritto internzionale e questo rappresenta un’indicazione importante per ribadire l’illeicità, oltre che il carattere criminale, del progetto israeliano e la necessità di difendere il diritto dei palestinesi ad avere una terra, uno Stato, una libertà oggi loro negata. Un supporto generale è dunque dato proprio dall’indignazione morale che in molte parti dell’Occidente si esprime anche nelle piazze. L’indignazione per il massacro infinito di un popolo inerme, per un’ingiustizia quasi secolare, per una sproporzione di forze indecente, per una narrazione occidentale ipocrita e in malafede asservita agli interessi di Usa, Ue e Israele. Quella che oggi caratterizza il governo Meloni che non a caso si rifiuta di riconoscere lo Stato palestinese ed esalta gli scontri di Milano come immagine chiave del 22 settembre per provare a mettere in ombra il proprio sostegno a Israele.
Era da moltissimo tempo che non si vedeva in strada un movimento di carattere internazionalista e in solidarietà a un popolo oppresso. A differenza del passato questa solidarietà si tinge fortemente di spinte umanitarie, ma riesce a intravedere anche le storture mondiali, economiche, sociali e politiche, che sorreggono l’oppressione e si interroga sui destini del mondo. Per questo, a rinforzare le piazze e le parole d’ordine sentite ovunque c’è anche il no alla guerra e in particolare il no al riarmo europeo e al militarismo trumpiano, che stanno caratterizzando le scelte e l’idea di società di un Occidente in crisi.
Una risorsa quindi morale, ma anche politica, come molte volte è avvenuto in mobilitazioni internazionaliste del passato, basti pensare al movimento contro la guerra in Vietnam ma anche a quello di inizio millennio contro la guerra in Iraq che fu definito «seconda potenza mondiale». Rispetto a quest’ultimo però, che fu enorme ma non riuscì a fermare la guerra, emerge oggi proprio la consapevolezza che per incidere è necessario provare a «bloccare tutto».
Se è vero che è nato un movimento, andrà quindi curato e fatto crescere, favorendo la sua autorganizzazione, con comitati e coordinamenti locali, e costruendo luoghi nuovi di convergenza tra organizzazioni di diverso tipo, che sappiano raccogliere questa spinta unitaria emersa dal basso. In forme che si spera possano imparare anche dall’urgenza della situazione in corso, sempre più proiettata verso una guerra globale.