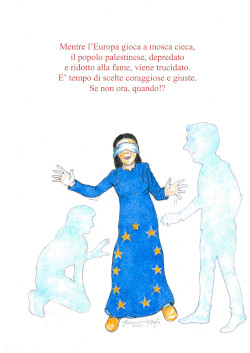La sentenza 96/2025 della Corte costituzionale (3 luglio) sul trattenimento nei centri per il rimpatrio è una misura dello stato di salute della Costituzione. La sentenza parte bene e arriva male. Riconosce una indubbia incostituzionalità, ma dichiara la inammissibilità delle questioni sollevate. In sostanza, la Corte rifiuta di occuparsene.
Nel nostro ordinamento i garanti della Costituzione sono due: il presidente della Repubblica e la Corte costituzionale, giudice delle leggi. Il presidente dispone di strumenti solo relativamente efficaci. Un rifiuto di promulgazione con rinvio della legge alle Camere potrebbe essere superato con una nuova votazione (art. 74 Cost.). Un rifiuto di firmare un decreto legge potrebbe essere bypassato con una iniziativa legislativa parlamentare, che ricadrebbe nell’ipotesi precedente. Nello scontro frontale con un governo sostenuto da una maggioranza parlamentare il presidente sarebbe destinato alla sconfitta. Questo non giustifica eventuali timidezze di Mattarella. Ma senza dubbio colloca la Corte in prima linea. Lo strumento di cui dispone è la dichiarazione di incostituzionalità. Nel tempo la Corte ha costruito una articolata tipologia di pronunce, di rigetto e di accoglimento. In particolare, le sentenze di accoglimento additive o sostitutive – che dichiarano una incostituzionalità della legge “in quanto non dice …” – sono intese appunto a “dire” qual è il diritto vigente, anche in sostituzione del legislatore. Un caso molto noto è la sentenza 242/2019.
La Corte scrive nell’art. 580 c.p. una compiuta disciplina per l’esclusione della punibilità nel caso di assistenza al suicidio. Qual è il punto debole della sent. 96/2025? Riconosce che il trattenimento nei centri impatta sulla libertà personale, garantita in Costituzione a tutti. Individua la incostituzionalità nella lesione delle riserve di legge e di giurisdizione, e nella mancata definizione in atti di rango legislativo delle modalità del trattenimento. Fin qui bene. Ma poi conclude che spetta esclusivamente al legislatore rimediare. Tecnicamente, la violazione della Costituzione è indubbia. Tuttavia, le questioni sollevate sono inammissibili.
Fingiamo di non sapere che l’odierno legislatore è ben poco disposto a seguire le indicazioni della Corte? Come accade per esempio per la sentenza 192/2024 sull’autonomia differenziata, sulla quale non si manifesta affatto l’intenzione di tener conto della lettura secundum Constitutionem avanzata dalla Corte? O per la sentenza 242/2019, sulla quale secondo le notizie di stampa l’intento di maggioranza sarebbe di peggiorare non poco le condizioni – già forse eccessive – ivi elencate? E cosa farà la Corte domani per la legge 80/2025 (già ddl Sicurezza), essendo la politica criminale un terreno sul quale ha tipicamente lasciato spazio al decisore rappresentativo? In realtà tutta la prima parte della Carta fondamentale è in sofferenza. Gianfranco Viesti su queste pagine argomenta che l’aumento della spesa militare al 5% distruggerà lo stato sociale. È una condanna senza appello. Ed è una campana a morto in specie per i Lep (livelli essenziali delle prestazioni) cari a Calderoli. Prima o poi arriverà in Corte in modo ultimativo la questione di un contenuto da garantire comunque. Si affiderà la Corte al buon cuore del decisore politico? Le libertà classiche e i diritti nuovi introdotti con la Costituzione del 1948 sono parimenti sotto pressione. Non possiamo permetterci afasia o timidezze da parte del garante primario della Carta.
Due corollari. Il primo. Le riforme si tengono insieme e vanno valutate per l’impatto complessivo. In specie, bisogna tenere conto della riforma (premierato e/o legge elettorale nell’impianto che piace a destra) che sposta l’asse del sistema di checks and balances nell’area di influenza della maggioranza pro tempore. Il che accade se è più facile raggiungere i numeri necessari per l’elezione del Capo dello Stato e dei membri della Corte costituzionale. Il secondo. L’indebolimento della democrazia rappresentativa e delle istituzioni di garanzia che un tempo avremmo ritenuto adeguate trova la sola risposta possibile nella democrazia diretta. A quanto ho già scritto su queste pagine aggiungo il progetto di una iniziativa legislativa popolare rafforzata, traducibile in referendum popolare (Conte-1, XVIII leg., AC 1173 e AS 1089). Una prospettiva poi abbandonata, e da riprendere.
La sentenza 96/2025 mi consolida altresì nella convinzione che sarebbe utile introdurre per la Consulta la dissenting opinion. Forse sarebbe possibile anche solo con la normativa interna della Corte. In passato, ho riscontrato qualche allergia dei costituzionalisti per l’idea, forse ritenuta lesiva della sacralità del giudizio sulle leggi. Ma c’è davvero sacralità nell’ipocrisia?